di Danilo Breschi
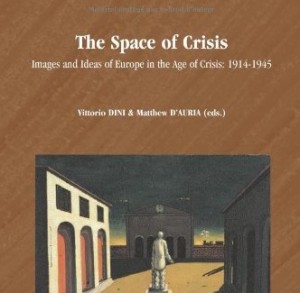
Ci sono molti modi in cui si può parlare di Europa, tema quanto mai attuale e forse anche inflazionato a livello di mass media. Un modo fecondo è quello di partire dall’idea di Europa, così com’è stata posta in momenti particolarmente delicati della storia politica, economica e culturale dei Paesi del continente. Sicuramente il periodo compreso tra l’inizio della prima e la fine della seconda guerra mondiale è uno dei più interessanti e ricchi di spunti, almeno con riferimento alla più recente storia europea. Il volume curato da Vittorio Dini e Matthew D’Auria (“The Space of Crisis. Images and Ideas of Europe in the Age of Crisis: 1914-1945”, P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2013) soddisfa ampiamente tutti questi requisiti e offre una panoramica abbastanza vasta di come e quanto l’alta cultura europea cercò di affrontare le sfide e le minacce gravissime poste all’identità dell’Europa. Minacce che non sempre apparvero come tali all’epoca. Nel senso che alcuni richiami all’Europa e ai progetti di unificazione del continente rispondevano a disegni di tipo nazionalista radicale e addirittura imperialista. Un’idea aggressiva di Europa, insomma. Lo nota bene il saggio di Jan Vermerein sul mito del “Reich” nel pensiero politico tedesco. Rispetto ad altri progetti che in quegli stessi anni furono elaborati per dare vita ad una unificazione dell’Europa, il concetto tedesco di “Reich” si connota per le radici cristiane e medievali che intende evocare, ma anche per la volontà di focalizzare la propria attenzione sull’area dell’Europa centrale e per la promozione, più o meno accentuata, che fa della leadership della Germania. Altro tratto distintivo è l’uso frequente di un linguaggio irrazionale ed emotivo, diversamente da quanto invece, sempre in lingua tedesca, esprimevano le idee di “Paneuropa” e “Mitteleuropa” promosse da personaggi del calibro di Coudenhove-Kalergi o il Principe Rohan.
Su questo punto il giudizio di Vermerein diverge parzialmente da quello di Anita Prettenthaler-Ziegerhofer, la quale dedica il suo saggio proprio all’analisi di queste due importanti idee, e relativi progetti politico-culturali, espressi in area austriaca. Sebbene essi fossero, e soprattutto si considerassero, “children of modernity” (p. 175), la loro attività teorica e pratica fu ampiamente segnata da un forte debito nei confronti del loro aristocratic background e della tradizione, in particolare quella greco-romana. Soprattutto è il caso di Karl Anton Prince Rohan. Ciò non significa che le loro proposte, soprattutto quella di Coudenhove, non abbiano mantenuto nel tempo molti elementi di validità e attualità. Su tutti il richiamo al ruolo che la cultura ha sempre avuto nella definizione di un’identità comune, senza la quale qualsiasi istituzione resta “politicamente inerte” (p. 176).
In area francese le ventate nazionaliste non mancarono, come sappiamo bene, ma si coniugarono assai meno con l’idea di Europa. La cultura francese nei primi del Novecento ribadiva per lo più il culto particolaristico dello Stato-nazione. Piuttosto ci furono, come nel caso di Paul Valéry, riflessioni su una possibilità di sopravvivere alla crisi innegabile che l’Europa stava attraversando all’indomani della prima guerra mondiale. Il saggio di Annamaria Ducci sottolinea il ruolo svolto dal grande poeta francese in qualità di presidente del Comité Permanent des Arts e des Lettres all’interno dell’Institut International de Coopération Intellectuelle of the League of Nations. Non diversamente in questo da Coudenhove o Rohan, Valéry espresse in quegli anni una visione pedagogica ed elitista della cultura. Anche in lui, comunque, l’impegno fu sempre rivolto all’edificazione di una comunità di Stati in pacifica convivenza e collaborazione. La sua fu un’evoluzione sofferta da posizioni più pessimistiche, espresse ne La Crise de l’Esprit, a posizioni maggiormente aperte alla speranza, culminate negli scritti della fine degli anni Trenta. I concetti di “classic” e “continuity” diventarono per lui delle ancore di salvezza di fronte all’aggressione culturale rappresentata dalle avanguardie nichiliste e da nuove mitologie barbariche provenienti dall’area germanica e slava. Ducci sottolinea poi certe incongruità che furono proprie non del solo Valéry ma dell’intera intellighenzia francese di orientamento liberale e moderato: proclamare al contempo l’universalismo e ritenere che la nazione francese fosse la vera ed unica corifea di questi valori universalistici grazie all’eredità della Rivoluzione del 1789.
Contributo originale e degno di particolare attenzione quello di Zoran Milutinović, dedicato alle diagnosi sulla crisi spirituale europea svolta da due significativi intellettuali serbi nel periodo tra le due guerre: Nikolaj Velimirović e Dimitrije Mitrinović. Il primo fu professore di teologia nonché vescovo della chiesa ortodossa serba; il secondo un intellettuale dai molteplici interessi e dal forte impegno civile e culturale, che lo portò a dar vita nei primi anni Trenta ad un gruppo di discussione che ebbe un largo seguito, sia pur breve, il New Britannia Movement. Amici tra loro, entrambi trascorsero gran parte della loro vita ed attività nel mondo anglosassone, tra Inghilterra e Stati Uniti. Entrambi ritennero che la crisi spirituale dell’Europa potesse trovare una soluzione solo e soltanto tornando ad attingere alla fonte primigenia, oramai essiccata: la Cristianità, unico e vero centro di gravità dell’identità comune del Vecchio Continente. Per il pacifista Mitrinović, in particolare, questa Cristianità poco aveva a che vedere con la religione del Nuovo Testamento e le istituzioni ecclesiastiche connesse. Indicava piuttosto “a complex ethical and psychological attitude” (p. 57), tanto che egli sviluppò poi un sincretismo religioso, “a cosmpolitan amalgamation of ideas and images, politically ambigous and rhetorically puzzling” (p. 65). Velimirović, invece, giunse infine a posizioni conservatrici e di un feroce nazionalismo. Nonostante questi differenti approdi finali, entrambi ritennero sempre che la salvezza dall’Apocalisse europea potesse provenire soltanto dall’Occidente e, più in particolare, per Mitrinović dalla Gran Bretagna, mentre per Velimirović dagli Stati Uniti.
Proprio l’America apparve invece a tanta parte dell’intellettualità europea, non solo francese, come la vera minaccia, se non addirittura la causa della grande crisi europea. E ciò anche prima del 1929. Nella costruzione dell’idea di Europa, fosse essa pacifica e cosmopolita oppure aggressiva e imperialista, la percezione degli Stati Uniti svolse un’influenza fondamentale, come si trattasse di un specchio, riflettente o deformante a seconda delle diverse interpretazioni ideologiche. Prevalse per lo più l’interpretazione negativa e denigratoria degli Stati Uniti. Di tutto questo parla in modo dettagliato il saggio di Richard Deswarte. Egli distingue tra “americanismo”, cioè il dibattito intellettuale sugli Stati Uniti, e “americanizzazione”, ovvero l’effettivo impatto dell’influenza americana sulla società europea, i suoi valori e i suoi stili di vita quotidiana. Insomma: l’imporsi di una american way of life. Si è soliti dire che l’americanizzazione si è dispiegata come processo inarrestabile solo a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, anche in virtù dell’esito di quel conflitto. Eppure assai diffusa fu la percezione che tale fenomeno fosse pienamente in corso già negli anni Venti. Una convinzione diffusa soprattutto negli ambienti di filosofi, storici e artisti. Si denunciò assai spesso l’avvento di una “Machine Society” anche nei Paesi europei a causa della crescente preponderanza della tecnica e dell’industria sin nei più reconditi aspetti della vita quotidiana. “Lo spirito contro la materia” fu espressione assai ricorrente, e il dato che più colpisce è che per molti di questi pensatori europei “it was not the American federal political system that engrossed them, but rather its modern rational economy and mass consumerist society” (p. 86).
Non fu così per una piccola ma agguerrita schiera di intellettuali italiani, tra cui Luigi Einaudi, Attilio Cabiati, di cui ci parla il saggio di Annamaria Amato (che prende in considerazione anche il contributo dell’industriale Giovanni Agnelli), e Carlo Rosselli, di cui invece si occupa il saggio di Matthew D’Auria. Per tutti questi personaggi il modello federale esercitò un grande fascino, e per alcuni di essi non mancò il riferimento esplicito all’esperienza politica americana. Altro tratto comune, che contribuisce a spiegarne l’europeismo pacifista e federalista, fu l’antifascismo, che in Rosselli culminò con il sacrificio della propria vita. Cabiati ed Agnelli si ispirarono direttamente all’idealismo di matrice wilsoniana, molto diffuso nell’Italia del primo dopoguerra, anche se ben presto travolto da un’ondata di nazionalismo e di antiliberalismo. Se tra le due guerre ci furono europeisti dichiaratamente democratici furono complessivamente pochi, ma quei pochi si annoverarono per lo più tra gli italiani. È questo un dato storiograficamente interessante e originale che emerge dalla lettura del volume. Con Rosselli, poi, la revisione in senso radicalmente riformista e liberale del socialismo si accompagnò, e anzi fu alimentata dalla forte vocazione europeista, dunque dalla critica assai severa del culto dello Stato-nazione. E così il federalismo rosselliano si contraddistingue ancora oggi per una particolare attenzione alla dimensione sociale. D’Auria sottolinea infine come socialismo e federalismo nascessero entrambi, per Rosselli, da un’esigenza di frantumare l’idea monolitica di sovranità in una serie di “spazi multipli” (p. 134).
Fra i molti intellettuali esaminati nel volume Carlo Rosselli è forse quello che più di altri mise in relazione le nozioni di “crisi” e “spazio” con riferimento alla situazione politica, sociale e culturale dell’Europa dopo il 1914. Una preoccupazione e una sensibilità teorica simile si trovano raramente nell’Europa di quel tempo, e analogie sono riscontrabili nel pensiero di John Dewey, a cui non a caso è dedicato il saggio di Adriano Vinale. Anche il filosofo americano mise drasticamente in questione l’idea dello Stato-nazione, non in modo pregiudiziale, ma solo perché constatava che storicamente molte sue funzioni o erano esaurite o si erano rovesciate in pesanti freni allo sviluppo di una società libera e pacifica. Ecco che anche per lui si pose la questione di pensare un nuovo ordine internazionale, questione ancora oggi sul tappeto, urgente come non mai.







Lascia un commento