
Gianni Scipione Rossi, Ladri di biciclette. L’Italia occupata, la guerra civile 1943-1945, la memoria riluttante, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2023, pp. 176, euro 15
di Guido Melis
 Confesso che prima che Gianni Scipione Rossi me lo rivelasse io ignoravo totalmente l’esistenza dello scrittore Luigi Bartolini; e tanto più ignoravo che egli avesse, in un suo libro del 1946, scritto la storia da cui fu tratto poi, ma con consistenti varianti, il capolavoro di De Sica e Zavattini Ladri di biciclette.
Confesso che prima che Gianni Scipione Rossi me lo rivelasse io ignoravo totalmente l’esistenza dello scrittore Luigi Bartolini; e tanto più ignoravo che egli avesse, in un suo libro del 1946, scritto la storia da cui fu tratto poi, ma con consistenti varianti, il capolavoro di De Sica e Zavattini Ladri di biciclette.
Naturalmente faccio pubblica ammenda della mia ignoranza. Tuttavia mi sono divertito, sapendo di dover presentare oggi il libro, a svolgere una mia piccola inchiesta personale tra amici e conoscenti di media cultura, scelti i più tra i sopravvissuti della generazione che visse gli anni ’40 e ’50. Ebbene, nessuno di loro conosceva Bartolini né tanto meno sapeva la storia del libro del ’46 (riedito – ci dice Gianni Scipione Rossi – nel 1948).
Lo racconto per introdurre subito un tema che mi preme molto: come si giudica un’opera d’arte che in qualche modo trae ispirazione da un prodotto letterario precedente? La mia risposta è una sola: la si giudica iuxta propria principia. Cioè la si apprezza per come reinterpreta (nel caso: per come letteralmente reinventa) la storia che ne ha costituito per così dire il primo spunto; la si valuta per come quella storia racconta; per come la riempie, quasi fosse un vaso vuoto, di contenuti freschi e originali.
Bartolini – ci dice Rossi – pensò persino di ricorrere a un giudice, invocando un diritto d’autore che all’epoca costituiva nel campo del diritto materia poco formata (abbiamo appena visto al proposito il film di Martone sul processo D’Annunzio-Scarpetta). E il cinema era allora un’arte giovane, con appena pochi decenni di vita. Ma al di là della eventuale sentenza, io penso che Bartolini avesse torto: era – mi si passi la brutalità – un mediocre autore di un’opera modesta, finita giustamente nel dimenticatoio; la coppia De Sica-Zavattini invece era geniale e ne avrebbe dato altre prove. Il film di De Sica, riscritto da Zavattini, è uno dei pilastri della stagione del cinema neorealista.
Sappiamo bene che quei film non piacevano in alto, all’ufficio censura della Presidenza del Consiglio degasperiana che il sottosegretario Andreotti aveva popolato di funzionari reduci dal Minculpop (lui sì, la memoria l’aveva subito “ricomposta” attingendo a piene mani a quel serbatoio d’anteguerra). Certo, quei film mettevano in scena un’Italia poverissima, becera, popolata di prostitute e lenoni, con le toppe nel sedere. Una rappresentazione tanto realistica dal risultare per il potere imbarazzante. Gianni Scipione Rossi cita a lungo Carlo Levi: ebbene, in uno dei racconti dello scrittore di Cristo si è fermato a Eboli apparsi nel dopoguerra sulla stampa quotidiana, si parla di un fatto di cronaca nera avvenuto a piazza Navona, dove un furtarello occasionale ad opera di un ragazzino del quartiere (siamo proprio a ridosso di via di Panìco, “la via dei ladri” come la chiamavano allora) provocò l’inseguimento pistola in pugno del padrone di un notissimo bar, che tuttora credo esista con lo stesso nome; e l’esecuzione a freddo del povero ragazzo. Ai cui funerali – racconta Levi – partecipò coralmente ammutolito dal dolore tutto il quartiere: una sfilata di lavoratori senza lavoro, di donne disperate, di persone travolte dalla guerra, di mendicanti, rottami umani e déracinès di ogni tipo. Ci sarebbe voluta la penna di Victor Hugo per raccontare al meglio quell’umanità dolente.
Questa era la Roma subito dopo la liberazione (4 giugno 1944), per non dire di quella dell’occupazione nazifascista (un mio amico, Antonio Areddu, ha di recente raccontato la curiosa ma tragica storia di un borsaro nero, Vita e morte di Alberto Coppola si chiama il libro); così fu poi la Roma degli anni della ricostruzione, quella dei cantieri di lavoro (che Fanfani, come risulta in un verbale del Consiglio dei ministri, contestava a ragione, opponendovi altri “rimedi”: uno fu, per fortuna, l’INA-casa). La Roma anche degli affari loschi, dei bambini senza padri venduti al miglior offerente o delle “segnorine” a caccia di militari americani, insomma del degrado economico e morale. Il libro di Rossi racconta questa Roma e lo fa benissimo: in certe pagine sembra un documentario, tanto sono realistiche le descrizioni.
Perché tra le virtù dell’autore – questo va subito detto – c’è l’arte rara del saper raccontare, intrecciando particolari, storie personali, dettagli e quadri d’insieme. Lo sapevamo già, avendo letto i suoi libri precedenti, ma se si voleva una prova che Rossi sia un bravo scrittore (e non solo, come lui si definisce con understatement, un giornalista), questo nuovo volumetto ne costituisce la prova.
Dunque lasciamoci adesso alle spalle il signor Bartolini, la cui trama originaria si riduceva alle banali peripezie di un proprietario derubato alla caccia della sua bicicletta nei meandri della Roma proletaria, e addentriamoci nel libro di Rossi.
172 pagine, dodici agili capitoletti che si leggono d’un fiato, una scrittura accattivante, poche note ma sempre essenziali. Molti i fatti, i nomi e gli eventi: nove pagine di fittissimo indice dei nomi testimoniano della pluralità delle vicende evocate. In scena ci sono gli anni tra caduta del nazifascismo e arrivo degli Alleati. E ci sono due temi, soprattutto, che possono considerarsi l’ossatura del libro e la sua spina dorsale.
Il primo è quello della memoria divisa che la guerra ha consegnato agli italiani. Caduto il regime che tutto aveva voluto e proclamato di unificare (le opinioni politiche e le ideologie, le classi sociali, i costumi) e che si definiva “totalitario”, l’Italia appariva scissa in due campi contrapposti: antifascisti e ex fascisti. Ma antifascisti come? Ed ex fascisti di quale tipo?
Ecco il merito di questo libro: che in ciò fa opera storiografica, giacché è compito dello storico prima di tutto conoscere, descrivere, capire; dividere ciò che appare come un tutt’uno. Mettere a nudo la sostanza delle cose.
Totalitario il fascismo, almeno alla maniera del nazismo e del bolscevismo, non lo era stato mai, e mi dispiace che un bravo storico che stimo come Emilio Gentile insista sulla tesi opposta (ancora nel giugno 2023 nelle due pagine della sua intervista resa a Simonetta Fiori su “La Repubblica”). Non lo fu perché non permeò di sé tutta la penisola, tutte le classi e tutte allo stesso modo. Non lo fu perché gli sopravvisse l’Italia al di là di Eboli, descritta magistralmente da Carlo Levi, e con essa la questione meridionale, la mafia in Sicilia mai sconfitta, i Sassi di Matera che una famosa inchiesta del dopoguerra sulla miseria (la prima con l’uso della macchina da presa: c’era una troupe al seguito dei parlamentari) avrebbero svelato agli italiani. Perché soprattutto – e lo si vide proprio quando (cito Galli della Loggia) morì la Patria e con essa lo Stato – sopravvisse però la famiglia, istituzione antichissima, privata, fondata su vincoli inestinguibili di sangue e di comunità: e fu quella la base della ricostruzione successiva del Paese.
Totalitarismo il fascismo? Tutt’al più imperfetto, animato dall’ambizione mai realizzata di esserlo ma privo di una reale penetrazione nel “privato” degli italiani. Per non dire delle istituzioni: ma ve lo immaginate voi Mussolini-duce supremo, come ce lo descrive Fulvio Suvich, in attesa nell’anticamera del re con la cartella dei decreti da far firmare al sovrano? Immaginate che qualcosa di simile potesse accadere a Hitler o a Stalin? Il crollo del 25 luglio testimonia del resto da solo che il progetto del fascismo era fallito, pure essendo durata la sua gestazione ben più a lungo di quella del disegno di Hitler.
Secondo tema, l’ossatura del libro. Rossi dedica molte pagine a quello che – se non si offende – chiamerei frugare nella cesta dei panni sporchi.
Certo che dopo il 25 luglio e ancor più dopo il 25 aprile ve ne furono di panni sporchi, e tanti. Lo testimoniano ormai una valanga di fonti. Certo che la generazione dei Littoriali, a cominciare dagli Ingrao, passò le linee e da promessa rivoluzionaria del secondo tempo del regime divenne il fulcro della generazione partigiana.
Se ve ne fosse bisogno racconterei qui una mia storia familiare che l’autore di questo libro conosce bene perché l’ha letta in una mia ricostruzione recente: è la storia di due ragazzi fascisti, capi gufini men che ventenni, nella Sassari “liberata” già al 25 luglio dalla precipitosa ritirata tedesca (la Sardegna non ebbe la sua guerra di resistenza, sebbene molti fossero i suoi caduti sul suolo “continentale”); la storia del lungo e doloroso cammino di questi due ragazzi verso la democrazia. Lungo e doloroso, ho detto: altro che accorrere in aiuto al vincitore come se nulla significasse il proprio passato.
In quei mesi fatali, dei due ragazzi divisi da banali circostanze di salute, uno indossò la divisa militare e maturò, tra le truppe sbandate di Badoglio, la sua revisione ideologica (che tuttavia fu lunga e sofferta e lo impegnò per almeno altri dieci anni); mentre l’altro, lasciatosi coinvolgere in un ridicolo tentativo di golpe fascista da fedelissimi del duce tra i quali forse un provocatore della Questura, dovette subire il carcere all’Asinara sino al 1946, e ne ebbe in cambio la tubercolosi che lo avrebbe più tardi portato alla morte.
Sto parlando – badate – di drammi umani: veri. Come furono, da una parte e dall’altra (anche tra chi in buona fede si arruolò a cercar la bella morte nelle truppe in camicia nera della Rsi), quelli vissuti da un’intera generazione.
Questo è il vero pregio del libro di Rossi : di averci rammentato questa tragedia nella tragedia. Di fronte alla quale i compromessi (veri o presunti che siano), il richiamo a quel che si scriveva e si giurava prima, la caccia al voltagabbana non servono a nulla. Un pezzo di quella generazione – fascistissimo in origine, anzi critico del fascismo reale per essersi allontanato da quello ideale – passò dall’altra parte. Non so chi abbia letto il libro di un giovane scrittore, Davide Orecchio, candidato l’anno scorso al Premio Strega: Storia aperta. Vale la pena di leggerlo, lo suggerisco: il protagonista, che è poi – mutato il nome – la il padre stesso dell’autore, è fascista, fascistissimo della prima ora, ha fatto la guerra in Etiopia (ed è lì anzi che gli sorgono i primi dubbi), ha attraversato contrastati amori, bollenti passioni e delusioni di vita; infine aderirà alla guerra partigiana e confluirà nel grande partito comunista che tutti accoglie: era stato Togliatti, del resto, nell’Appello ai fratelli in camicia nera, nel 1936, a preparare quello sbocco che attrasse poi moltissimi giovani di Mussolini. Va letto, il libro di Orecchio, anche nella seconda parte dove il protagonista perde a una a una le sue illusioni rivoluzionarie, dopo quelle fasciste anche quelle comuniste: la letteratura a volte vale più della storiografia, coglie meglio e più nitidamente i problemi complessi che suscitano simili sommovimenti generazionali.
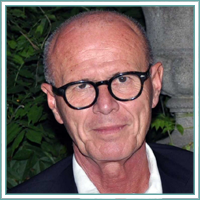 Gianni Scipione Rossi (a sinistra, nella foto)auspica in questo libro la ricomposizione della memoria divisa. Non è, voglio credere, l’amnesia storica; non è, sono sicuro, la cancellazione del fascismo e dei suoi delitti, dall’assassinio di Matteotti alle leggi razziali. È un andare avanti, che in fondo può assimilarsi a quanto pensava Togliatti (di nuovo lui, con tutto lo stalinismo che gli grondava ancora addosso), quando promosse saggiamente la grande amnistia.
Gianni Scipione Rossi (a sinistra, nella foto)auspica in questo libro la ricomposizione della memoria divisa. Non è, voglio credere, l’amnesia storica; non è, sono sicuro, la cancellazione del fascismo e dei suoi delitti, dall’assassinio di Matteotti alle leggi razziali. È un andare avanti, che in fondo può assimilarsi a quanto pensava Togliatti (di nuovo lui, con tutto lo stalinismo che gli grondava ancora addosso), quando promosse saggiamente la grande amnistia.
Ma per andare avanti, per metabolizzare quanto era accaduto, sarebbe stato necessario – prima – realizzare una epurazione vera, con leggi chiare e non contraddittorie (lapidariamente critico il giudizio che ne diedero due giovani grandi giuristi vicini a Nenni, Massimo Severo Giannini e Giuliano Vassalli) e con giudici non conniventi con gli imputati. Epurare non degli stracci messi a volare perché innocui, vittime in fondo essi stessi, ma i reali responsabili: i capi violenti e anche i tanti, magari di estrazione liberale prefascista, che erano stati a guardare, quando non si erano accomodati sulle comode poltrone del nuovo potere loro offerte dal vincitore.
Santi Romano, giurista sommo e maestri di tutti noi, il primo a insegnarci che esisteva il pluralismo degli ordinamenti giuridici (altro che lo Stato-monumento idolatrato dal duce), fu dal 1928 al 1943 presidente del Consiglio di Stato. Poi gli si intentò un processo per epurarlo, processo schivato (come fece del resto gran parte della magistratura) dimettendosi dalla carica e con ciò vanificando le accuse. Rossi non lo cita mai: ma Romano era l’autore del celebre parere giuridico sul duce primo maresciallo dell’Impero, l’unico atto fascista che mandò in bestia il re, futuro sottoscrittore delle leggi razziali.
Decine di importanti personalità dell’economia, della politica, della cultura se la cavarono senza danni. Rossi fa in una pagina il processo a Moravia per certe gite negli Stati Uniti finanziate dal Minculpop: ma Moravia era del 1907, aveva cioè solo 24 anni quando pubblicò quel formidabile j’accuse contro la società italiana del tempo fascista che è Gli indifferenti. Il fascismo non vi è mai nominato, d’accordo: ma quel libro vale come una bomba contro la falsa morale e la corruzione di una piccola borghesia che, in quegli stessi anni, indossava la camicia nera e sfilava ogni sabato, fiera e impettita, sotto i gagliardetti del duce.
Questo era ed è ancora il punto: il fascismo, come scrisse Mussolini, mi pare nel breve esilio della Maddalena dopo la sua prima caduta, non aveva in fondo inventato nulla. Aveva trovato un popolo già pronto a indossare la camicia nera. E chissà, forse anche a dismetterla per indossarne poi qualunque altra.



Lascia un commento