di Giulio De Ligio
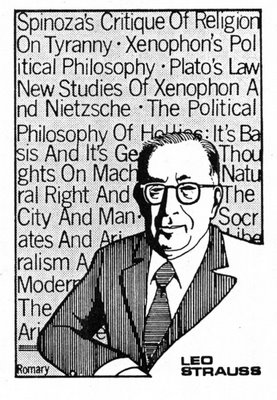 Quando ci si chiede quali possano essere oggi il compito intrinseco e la responsabilità politica del pensiero, il punto di partenza meno arbitrario è forse offerto dalla meditazione dell’autocoscienza delle società europee. Non pare, in queste ultime, isolata l’impressione di un’incipiente impotenza, di una contrazione dell’orizzonte della vita comune e di un abbassamento dei suoi fini. Non sono più necessarie attitudini critiche verso l’avventura moderna per paventare o riconoscere la perdita di statura politica e morale di nazioni e uomini europei: consapevolezza teorica e coscienza del politico, amor del vero e attenzione al bene comune impongono congiuntamente che di questa situazione si interroghino le cause, che si ritorni ai princìpi.
Quando ci si chiede quali possano essere oggi il compito intrinseco e la responsabilità politica del pensiero, il punto di partenza meno arbitrario è forse offerto dalla meditazione dell’autocoscienza delle società europee. Non pare, in queste ultime, isolata l’impressione di un’incipiente impotenza, di una contrazione dell’orizzonte della vita comune e di un abbassamento dei suoi fini. Non sono più necessarie attitudini critiche verso l’avventura moderna per paventare o riconoscere la perdita di statura politica e morale di nazioni e uomini europei: consapevolezza teorica e coscienza del politico, amor del vero e attenzione al bene comune impongono congiuntamente che di questa situazione si interroghino le cause, che si ritorni ai princìpi.
L’Europa cerca da tempo di dare un volto alla sua crisi, e così di nuovo un nome a se stessa, anche prima di quelle che si sono avvicendate e sovrapposte nel primo decennio del nuovo millennio. La «soluzione economica del problema politico» che è giunta a identificare il movimento del regime liberal-democratico non è più vissuta o creduta come soluzione e il continente politico-spirituale in cui quel movimento si è dispiegato non si rivela sempre perfettamente abitabile per l’uomo: le fondamenta «basse ma solide» su cui il regime liberal-democratico poggia le sue rivendicazioni di giustizia e ragionevolezza si dimostrano in misura crescente «troppo basse e non così solide» e l’ambivalente emancipazione della tecnica dal controllo morale e politico da cui dipende l’opulenza, se non la stessa tenuta, dell’ordine delle libertà moderne invita alcuni a chiedersi nuovamente se non sia solo «un» Dio a poterci ormai salvare. La realizzazione dei princìpi che animano l’ordine moderno non cessa in qualche misura di procedere (di «generare» diritti umani), ma l’ideale realizzato non sembra più tale e finisce per disertare l’uomo produttore inintenzionale di quella giustizia. La Città europea non crede più nel suo progetto globale e può al massimo anelare – abbandonata invisibilmente la proclamazione del «progresso» – al «cambiamento» o alla «modernizzazione».
Sorge il sospetto, supportato da qualche buona ragione, che non tutte le speranze o i progetti che ispirano i nostri princìpi siano ben riposte o fondate, che l’universale domenica della vita non sia alle porte. Sorge il sospetto che il vero agire politico non abbia perso la sua necessità e la sua opaca nobiltà, che occorra recuperare la sua coscienza e la sua scienza, e che si imponga perciò un rinnovato confronto con la voce di quanti hanno provato a indicare una via verso la responsabilità politica rendendo percorribile al contempo anche quella, in parte comune, che conduce alle questioni permanenti e fondamentali.
In questa ricerca, pochi spiriti offrono un ricorso altrettanto istruttivo di quello platonico e un po’ talmudico di Leo Strauss. Giunto alla constatazione per molti stupefacente, anacronistica o oscura che la «crisi del nostro tempo» debba essere ricondotta alla «crisi della filosofia politica» (per evocare un suo denso e sintetico testo di inizio anni sessanta), Strauss fornisce ancora oggi un punto di partenza impegnativo ma fecondo per ritrovare la fondatezza, il nocciolo costitutivo e l’urgenza di quelle inesauribili questioni e per far luce su quel paradosso oggi «eluso» che Nicolas Gómez Dávila ha inquadrato con la consueta acutezza in due dei suoi onnicomprensivi aforismi: «Il problema politico ha un’importanza estrema, le soluzioni politiche nessuna»; «il problema autentico non chiede di essere risolto, chiede che si tenti di viverlo». Anche noi oggi torniamo a interrogarci sulla natura del problema politico e sulla sfuggente possibilità di una sua soluzione – quasi a dar prova, con la nostra stessa perplessità, che quella soluzione non coincide, appunto, con il nostro presente, con il reale.
In questo orizzonte l’invito a rimeditare la lezione di Strauss viene quasi imposto dalla recente ripubblicazione della celebre conferenza tenuta dal filosofo di Kirchhain – significativamente, non va dimenticato «per un solo momento», alla Hebrew University di Gerusalemme – nel dicembre del 1954 e nel gennaio del 1955 e in seguito ampliata e pubblicata con il titolo socratico Che cos’è la filosofia politica? (ora Il Melangolo, Genova 2011). Non è qui ovviamente possibile anche solo rievocare la messe di intuizioni interpretative, di ricostruzioni insieme sobrie e folgoranti, che accompagnano l’argomentazione straussiana né le tante questioni – mai de minimis rebus – che questa fa sorgere o lascia in sospeso nel suo tentativo di riabilitare non già un «ambito» della scienza o della prassi, una «provincia della cultura», o una concezione del mondo tra le altre, quanto un sapere adeguato all’esperienza umana nel suo costitutivo rapporto al Tutto (p. 44). Possiamo qui limitarci ad indicare l’esito dell’argomentare di Strauss o il motivo non edificante o volontaristico ma oggettivo che suggerisce di ardire al confronto con il testo: nella città che «più seriamente» ha considerato e manifestato «il tema della filosofia politica», Strauss si avventura nella presentazione della «soluzione» che di questo hanno delineato Antichi e Moderni e rende nuovamente plausibile e anzi ineludibile per lo sguardo tutta la «latitudine» del problema politico, e così anche la portata umana e scientifica del suo oblio o della sua negazione positivistica o storicistica. Riscoprirne i veri termini, anche a prescindere dalle specifiche conclusioni cui giunge Strauss, significa tornare a ricercare il miglior continente politico-spirituale in cui prospera il pensiero e ben si orienta l’agire, e dunque anche ciò che nelle loro vie forse altre l’amor del vero e l’istinto politico condividono.
L’argomentazione di Strauss quasi impone quella rinnovata «navigazione». Nel mutevole reame che le appartiene – in cui regna la prudenza – l’azione politica ha certo un’irriducibile specificità «pratica», ma si propone la conservazione o il cambiamento (le «riforme»): è dunque guidata dall’opinione sul meglio o sul peggio verso cui dirigersi e implica così sempre un’idea del bene o una gerarchia dei fini e delle urgenze (p. 10). È proprio delle cose politiche di non esser neutrali bensì soggette ad approvazione o disapprovazione, scelta o rifiuto, lode o biasimo, e di imporre pertanto la decisione e il giudizio degli uomini (p. 12). Questa loro implicita o esplicita richiesta di essere giudicate in termini di giustizia e ingiustizia non è sospesa in un cielo arbitrario, perché il giudizio può ricercare i migliori criteri e perché la ragione umana non è cieca e muta di fronte al «conflitto tra i diversi valori» (p. 25). Non è perciò giustificato né possibile sottrarsi al problema politico delegando al «processo del mondo» la responsabilità di determinare la buona società (o la vera umanità dell’uomo) e di discernere tra le pur imperfette alternative – «nobili o ignobili» – che ogni epoca presenta. Come Strauss ricordava anche nel suo fondamentale dialogo con Schmitt, il politico deve a una simile questione la sua perdurante serietà che si può disconoscere solo al prezzo – l’enfasi pare in questo caso fondata – dell’umanità dell’uomo: «L’ambiguità del fine politico è dovuta al suo carattere globale. Così sorge la tentazione di negare, o evitare, il carattere globale della politica e di trattare la politica come un compartimento a sé stante tra molti. A questa tentazione si deve però resistere, se è necessario affrontare la nostra situazione come esseri umani, vale a dire nella sua interezza» (p. 18). In questo duplice e correlato apporto, che rinnova la sua rilevanza nella situazione presente, Strauss rende plausibili le luci più intense della vita umana proprio recuperando il chiaroscuro della sua condizione politica: per questo testi come la lezione di Gerusalemme continuano dopo decenni a presentarsi, tra le loro oscurità, come una proposta congiunta di moderazione e audacia – forse ancora udibile in un tempo che pare saturato da una passione per l’individualità che si rivela al contempo smisurata e docile, ubiqua e ristretta, comprensibile e sconfortante, davvero a volte una travolgente e informe «joyless quest for joy».
Per noi che abitiamo oggi quella «regione», evocata da Strauss nella quasi struggente apertura, in cui il ricordo della visione dei profeti e l’anelito per la «Città giusta» sembrano talvolta sul punto di svanire completamente, ritrovare la necessità del problema politico e la possibilità della sua scienza darà forse nuova vita anche a quell’anelito eterno eppur oggi sopito, alla ricerca di quei «grandi scopi dell’umanità [..] che sono capaci di elevare tutti gli uomini oltre il loro misero io» (p. 10), al desiderio di politica – astunomous orgas – e di ciò che eccede in grandezza o perfezione la Città – i suoi veri limiti.






