
di Davide Ragnolini
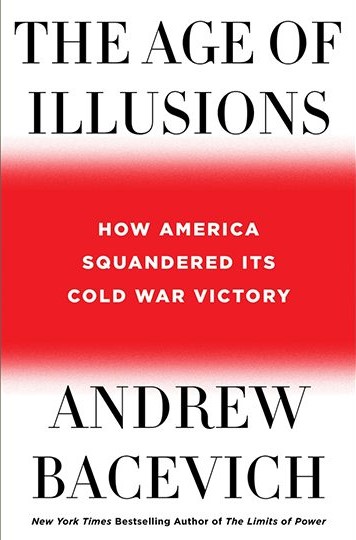 “Illusione”, “pace delle illusioni”, “grande delusione”, e di nuovo “età dell’illusione”: dal lontano articolo di Reinhold Niebuhr del 1949 – uno degli autori preferiti di Obama – sul governo mondiale, alla teoria neorealista di Christopher Layne e John Mearsheimer nel XXI secolo, fino all’ultimo lavoro di Andrew Bacevich (The Age of Illusion, Metropolitan Book, New York, 2020, vedi foto della copertina a sinistra), i termini che rappresentano il protagonismo internazionale statunitense non lasciano adito a dubbi. L’illusorietà è diventata il coefficiente linguistico che esprime più concisamente lo status quo dell’ordine internazionale, lo scarto tra la sicumera ideologica della leadership statunitense e la realtà.
“Illusione”, “pace delle illusioni”, “grande delusione”, e di nuovo “età dell’illusione”: dal lontano articolo di Reinhold Niebuhr del 1949 – uno degli autori preferiti di Obama – sul governo mondiale, alla teoria neorealista di Christopher Layne e John Mearsheimer nel XXI secolo, fino all’ultimo lavoro di Andrew Bacevich (The Age of Illusion, Metropolitan Book, New York, 2020, vedi foto della copertina a sinistra), i termini che rappresentano il protagonismo internazionale statunitense non lasciano adito a dubbi. L’illusorietà è diventata il coefficiente linguistico che esprime più concisamente lo status quo dell’ordine internazionale, lo scarto tra la sicumera ideologica della leadership statunitense e la realtà.
Non si può nemmeno parlare di leadership globale, dal momento che questo ruolo e i suoi stessi aspiranti storici sono stati sistematicamente sfidati all’interno della struttura internazionale. La stessa idea di leadership statunitense ha incontrato diverse difficoltà di periodizzazione. Vi è chi recentemente, come Mearsheimer, ha parlato di età aurea dell’ordine liberale (1990-2004) e della sua fase discendente in corso (2005-2019); chi, come Patrick Deneen, ha interpretato questo declino della globalizzazione a guida statunitense come crisi complessiva dell’ideale rappresentato dal liberalismo politico; e ancora chi, come Bacevich, ha suggerito con l’amministrazione Trump l’avvento della fine del “consensus post-guerra fredda”.
Nella prospettiva di Bacevich il declino del soft power americano e dell’ordine liberale sono intese non soltanto come conseguenza di una crisi strutturale internazionale, un fatto che di per sé interesserebbe soltanto gli studiosi di questioni internazionalistiche e di geopolitica (ancora relativamente ai margini, in realtà, nel nostro dibattito quotidiano); la crisi è anche il segno di una diminuita capacità di proiezione ideologica positiva della società statunitense, che mostra invece alcune faglie e contraddizioni che la attraversano sul piano interno e sul lungo periodo. Una società che ci ha abituati – e la forza dell’abitudine nelle false credenze, lo insegnava già Aristotele (Met. II, 3 955a), può essere nefasta – all’idea che il concetto di Occidente rappresenti una nozione geopolitica ed ideologica neutrale e culturalmente omogenea, e che il baricentro del modello culturale novecentesco si fosse spostato dall’Europa all’Atlantico.
Ciò che chiamiamo ‘globalizzazione’, come è noto, è in realtà un concetto più sfuggente di quanto si creda. In primo luogo perché designa un processo economico-politico che non ‘globalizza’ in modo omogeneo: non esiste globalizzazione senza una certa asimmetria e disuguaglianza tra le nazioni. In secondo luogo, perché non costituisce affatto un fenomeno pacifico, ma anzi aumenta drammaticamente la temperatura geopolitica di alcune ‘zone calde’ del pianeta (oltre che quella climatica dell’antropocene).
Ma c’è un altro modo, disilluso, di guardare alla globalizzazione: per Bacevich questa ha rappresentato la pietra angolare della “super-story” statunitense dopo la guerra fredda. Lo strumento persuasivo per narrare una storia – quella del mondo post-bipolare – che ci ha mostrato un ‘happy-ending’ molto più infelice di quanto promettesse. Negli anni ’90, l’interventismo statunitense aveva mostrato la pusillanimità degli alleati europei nell’ex Jugoslavia e la debolezza della Russia post-sovietica; dalla seconda guerra in Iraq in poi, Washington ha conosciuto serie resistenze al suo soft e hard power.
La crisi di legittimità nell’eurozona oggi suggerisce, forse, che la pusillanimità della classe dirigente europea e la sua assenza di coesione sia diventata qualcosa di tangibile per l’opinione pubblica di diversi Paesi del vecchio continente, e non soltanto per l’élite americana. Ma il recente focolaio della questione razziale negli Stati Uniti ci mostra un fenomeno simile, che interessa una buona parte dell’opinione pubblica statunitense. Un fenomeno sì interno, ma che – come in parte aveva previsto Bacevich – non sarebbe stato privo di conseguenze sul piano esterno.
L’erosione del soft power statunitense dipende non solo dalle sue scelte strategiche esterne, ma dalle difficoltà di superare specifiche, e mai sopite, difficoltà socio-culturali. Oltre alla persistente discriminazione razziale di “vecchio stile” (old-fashioned, direbbe Bacevich) e allo stato di emergenza sanitaria, si sommano dati drammatici sulla salute, fisica e culturale, della società statunitense: 33000 circa cittadini muoiono annualmente in scontri per armi da fuoco; il 40% di adulti è in condizione di obesità; circa 16 milioni di adulti soffrirebbero di depressione; il tasso di incarcerazione è il più alto al mondo e quello di natalità ai minimi storici.
Quel “consensus post-guerra fredda” che è stato accolto, nella regione euro-atlantica e non solo, con acritico entusiasmo, si è ormai incrinato. Secondo Bacevich i ‘pilastri’ che hanno sorretto questo consensus e il protagonismo statunitense sono stati diversi: la promozione di un neoliberalismo globalizzato, l’ambizione a leadership globale della Casa Bianca, la revisione del concetto di ‘libertà’ nel mondo post-bipolare, e infine la supremazia presidenziale sul piano domestico. Eventi interni ed esterni hanno messo a dura prova la tenuta di questo ambizioso edificio. Non da ultimo, l’attuale crisi pandemica globale, a cui si accompagna un generalizzato ‘statocentrismo’ di ritorno.
Ma un altro fenomeno, speculare su entrambe le sponde dell’Atlantico, ha interessato infaticabilmente i politologi negli ultimi anni: la crisi delle forze politiche centripete in Europa, e del supporto bipartisan al “consensus post-guerra fredda” negli Stati Uniti. Il declino del soft power statunitense ha origini più profonde dell’elezione di Trump: per buona parte del mainstream mediatico il tycoon avrebbe invece rappresentato, dal 2016 in poi, un utile ‘parafulmine’ per misconoscere cause più strutturali del disordine internazionale contemporaneo.
Lo sguardo di Bacevich sull’età contemporanea delle relazioni internazionali suggerisce una prospettiva che non può essere elusa. Possiamo usare lenti più o meno deformanti, e guardare rispecchiato nella realtà geopolitica soltanto ciò che vorremmo. Oppure potremmo, più realisticamente, riflettere su alcune illusioni ottiche dell’età post-bipolare. Del resto, la stessa disciplina delle Relazioni Internazionali – si dice – sarebbe nata proprio con la critica ad una ottimistica opera del liberale britannico Norman Angell: “La grande illusione” (1910), che apparve l’anno precedente con il titolo “L’illusione ottica dell’Europa”. E una ripresa della teoria internazionale oggi, forse, potrà avvenire soltanto prendendo seriamente in considerazione le nostre più generalizzate illusioni di fine XX secolo.







Lascia un commento