
di Alessandro Campi
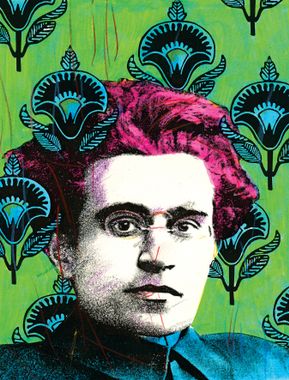 Ciò che il fronte populista teme di più, per il futuro delle democrazie, è lo strapotere delle élite (economico-finanziarie e d’altro tipo): talmente forti da orientare le scelte politiche fondamentali a misura dei propri interessi e senza tenere conto della volontà dei cittadini. Da qui l’idea che esse siano non un esempio da seguire, come nel passato, quando appunto si pensava che le élite rappresentassero una sorta d’avanguardia della società alla quale appartenevano i più meritevoli e capaci, ma una minaccia da neutralizzare, essendo nel frattempo divenute un blocco chiuso e autoreferenziale che si batte solo per accrescere il proprio potere.
Ciò che il fronte populista teme di più, per il futuro delle democrazie, è lo strapotere delle élite (economico-finanziarie e d’altro tipo): talmente forti da orientare le scelte politiche fondamentali a misura dei propri interessi e senza tenere conto della volontà dei cittadini. Da qui l’idea che esse siano non un esempio da seguire, come nel passato, quando appunto si pensava che le élite rappresentassero una sorta d’avanguardia della società alla quale appartenevano i più meritevoli e capaci, ma una minaccia da neutralizzare, essendo nel frattempo divenute un blocco chiuso e autoreferenziale che si batte solo per accrescere il proprio potere.
Ciò che la sinistra socialdemocratica e liberale considera letale per il futuro delle democrazie occidentali è invece l’affermarsi di leadership politiche sempre più solitarie, assolute e pericolosamente inclini all’autoritarismo. Nel vuoto creato dalla crisi dei partiti politici e degli altri organismi di rappresentanza collettiva, le decisioni politiche che contano sembrano dipendere sempre più dalla volontà di singoli capi politici, la cui forza non è rappresentata solo dai voti che raccolgono nelle elezioni in virtù dei loro programmi, ma dal consenso popolare che riescono a costruire grazie a un uso spregiudicato e manipolatorio dei nuovi strumenti di comunicazione di massa.
L’impressione, se si guarda alla realtà che abbiamo sotto gli occhi, è che si tratti di due preoccupazioni politiche egualmente infondate, o almeno esagerate. Si potrebbe dire che il problema delle democrazie contemporanee (a partire da quella italiana) è rappresentato semmai dal contrario; da un lato, dalla mancanza di élite o gruppi dirigenti capaci di orientare le azioni e le opinioni dei cittadini, di offrire loro modelli virtuosi di comportamento e di suggerire alla società una direzione di marcia coerente; e dall’altro dalla mancanza di leader dotati di una forza decisionale effettiva, di un profilo politico capace di durare nel tempo e di una visione sufficientemente chiara dei problemi che caratterizzano il mondo contemporaneo e degli strumenti necessari a risolverli.
Per quello che riguarda le élite nelle odierne società democratiche, la loro colpa maggiore non è di avere troppo potere (e di esercitarlo senza alcun controllo o limite), ma di aver rinunciato alla loro funzione storico-sociale e alle responsabilità (anche d’ordine etico) che dovrebbe comportare il fatto di occupare il vertice della piramide sociale. Le élite socio-politiche contemporanee – lo sosteneva già un ventennio fa il compianto Christopher Lasch – hanno progressivamente abbandonato il loro storico ancoraggio statual-nazionale, per abbracciare stili di vita e modelli culturali diversi da quelli diffusi a livello popolare nelle rispettive società, verso i quali si è cominciato a manifestare un crescente disprezzo intellettuale. A questo divorzio socio-antropologico tra élite e masse si deve poi aggiungere, come dimostra in particolare il caso italiano, l’incapacità di queste stesse élite a contrastare un clima d’opinione orientato alla loro delegittimazione sociale e basato sull’idea che una vera democrazia non possa tollerare l’esistenza di minoranze che in quanto tali sono soltanto foriere di intollerabili privilegi.
Contro questa visione distorta e semplificata della democrazia bisognava battersi con argomenti razionali e senza operare compromessi, svelando ad esempio il trucco ideologico che si nasconde dietro la critica populista alle élite: accusarle di ogni nefandezza col solo obiettivo di prenderne il posto senza altro titolo che la veemenza della propria polemica. La reazione delle élite messe sotto accusa è invece andata in altre direzioni, entrambe sbagliate: quella dell’invettiva contro i populisti, accusati di essere globalmente una minaccia per la democrazia senza nemmeno chiedersi se le loro posizioni critiche contro certe derive oligarchiche della politica avessero una qualche plausibilità; e quella dell’accettazione in chiave omeopatica della retorica populista, nella convinzione che assecondarla potesse tornare utile in chiave elettorale e potesse servire a neutralizzarla. Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi in Italia in questo momento storico: una democrazia priva di minoranze dirigenti (non solo e non tanto d’origine politica) delle quali i cittadini possano fidarsi o nelle quali possano rispecchiarsi. Ma è una condizione che si registra anche in altri Paesi europei.
Un discorso analogo può farsi per il rischio, che alcuni paventano, di una deriva eccessivamente personalistica dei nostri sistemi politici. L’idea che le deboli democrazie contemporanee – caratterizzate da elettorati sempre più volatili, con sistemi partitici sempre più frammentati e alle prese con un ciclo economico che ne limita strutturalmente le capacità operative – possano produrre capi forti, come tali sottratti al controllo politico del Parlamento e dell’opinione pubblica, è in realtà sbagliata. Una democrazia istituzionale debole produce di conseguenza leader politicamente deboli. Il fatto che molti capi politici o di governo riescano oggi a conquistare un forte seguito di massa non significa che siano anche autorevoli e in grado di realizzare le ricette davvero necessarie alla vita delle rispettive collettività. I leader contemporanei, diversamente da quelli del passato, costruiscono ormai la loro immagine pubblica e i loro programmi politici sempre più a misura degli umori popolari e dei sondaggi d’opinione. Ma il pericolo è di restarne alla fine prigionieri.
Non solo, ma l’enfasi ossessiva che ormai essi pongono sulla comunicazione – che per essere efficace deve essere sempre più istantanea, martellante, basata su poche parole e su slogan costruiti a misura della polemica del giorno – espone le loro carriere politiche ad una grande precarietà: tanto velocemente si affermano, altrettanto velocemente rischiano di declinare. Laddove ciò che dovrebbe per definizione caratterizzare un leader politico è la sua capacità a durare nel tempo, a superare le contingenze avverse, a non inseguire le idiosincrasie dei suoi elettori, semmai a governarne o indirizzarne le pulsioni deteriori. Anche la tendenza odierna a modellare il proprio stile di governo sul linguaggio e sul modo di pensare del cosiddetto ‘elettore medio’, senza porre alcuna distanza tra se stesso (e la funzione che si ricopre) e il cittadino per conto del quale si regge la macchina pubblica, rischia di produrre forme deboli di leadership: ciò che nell’immediato si guadagna in popolarità e simpatia, si perde infatti in autorevolezza.
Non abbiamo più élite socialmente legittimate e consapevoli del loro ruolo direttivo e rischiamo al tempo stesso di avere, invece che capi politici che guidano i cittadini, leader “usa e getta” che si limitano ad assecondarne le frustrazioni e ad alimentarne le false speranze. Ciò significa che nelle democrazie odierne non è il potere – dei pochi e dell’uno – che dobbiamo temere. Ma la sua latitanza ed evanescenza nell’illusione che possa essere di tutti.







Lascia un commento