di Danilo Breschi
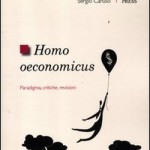 “Crisi” è oramai diventata la parola più inflazionata tra Europa ed America, l’Occidente del tempo che fu. È un concetto usato in modo vago ed onnicomprensivo, ma oggi è sulla bocca di tutti come sinonimo di “crisi economica”, o, per alcuni, di “crisi del capitalismo”. Ma cosa è mai questa crisi dell’economia occidentale?
“Crisi” è oramai diventata la parola più inflazionata tra Europa ed America, l’Occidente del tempo che fu. È un concetto usato in modo vago ed onnicomprensivo, ma oggi è sulla bocca di tutti come sinonimo di “crisi economica”, o, per alcuni, di “crisi del capitalismo”. Ma cosa è mai questa crisi dell’economia occidentale?
È essenzialmente una crisi da auto-inceppamento di un sistema che produce sempre meno merci e beni di consumo, sempre meno valori di scambio e sempre più valori d’uso. Denaro che produce denaro. Tanta speculazione, poca economia reale.
Niente di nuovo, se è vero che già nel 1986, nel celebre film 9 settimane e ½, il bello e maledetto Mickey Rourke rispondeva così ad una inquieta e conturbante Kim Basinger, che gli chiedeva cosa facesse nella vita: “faccio soldi con i soldi”. Questa la risposta che l’anno successivo si sarebbe incarnata in un altro immortale personaggio del cinema degli anni Ottanta: lo speculatore finanziario e insider trader Gordon Gekko, interpretato da Michael Douglas nel film Wall Street di Oliver Stone.
Gekko è diventato il simbolo dell’avidità smisurata e spietata. Suo il motto “l’avidità è buona. L’avidità è giusta”. Più in particolare, Gekko afferma che “l’avidità funziona. […] l’avidità chiarisce e coglie l’essenza dello spirito evolutivo. L’avidità in tutte le sue forme: l’avidità per la vita, per il denaro, per l’amore, la conoscenza, ha segnato l’avvento e l’ascesa dell’umanità, […] e salverà anche quell’altra azienda mal funzionante chiamata Stati Uniti d’America”.
L’ampia citazione aiuta a sintetizzare l’essenza del concetto che sta alla base della scienza economica mainstream e il tipo di uomo, con Weltanschauung annessa, che essa presuppone e impone. E come ha detto nell’ottobre del 2008 Kevin Rudd, primo ministro australiano, in un discorso non a caso intitolato I figli di Gordon Gekko: “Forse ora è arrivato il momento di ammettere che non abbiamo imparato tutta la lezione dell’ideologia dell’‘avidità è buona’. E oggi stiamo ancora ripulendo il disastro lasciatoci dai figli di Gordon Gekko del XXI secolo”. Gekko: dalla realtà alla fantasia, l’andata nel 1987 e il ritorno vent’anni dopo. Niente di nuovo, dunque, ma molto di consequenziale.
L’homo oeconomicus è il presupposto teorico di buona parte dell’ideologia mercatista contemporanea. Se allora vogliamo provare ad uscire dalla crisi, quanto meno ad imboccare la via giusta per accorciare la traversata dentro al tunnel, occorre che smantelliamo la “filosofia” che sta dietro e dentro la forma contemporanea del capitalismo finanziario e speculativo. Si tratta di una perversione che ha cause recenti ma anche presupposti teorici di lungo corso, addirittura originari. Questo è appunto il caso del concetto di “uomo economico”, dove quell’aggettivo vuole qualificare e risolvere l’intera natura umana, o almeno le sue inclinazioni più profonde e le sue aspirazioni ultime, espungendo ogni elemento passionale come ogni condizionamento storico e culturale.
Per cominciare ad impostare bene il problema ci viene ora in aiuto uno studio di Sergio Caruso, docente di Filosofia delle scienze sociali presso l’Università di Firenze (Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni, Firenze University Press 2012). Unendo competenze da filosofo e da psicologo, Caruso passa in rassegna un ampio ventaglio di critiche che la storia del pensiero politico, economico, antropologico e psicologico, ma anche letterario, ha prodotto sulla figura dell’homo oeconomicus sin dai tempi della sua prima comparsa. Tempi che non iniziano affatto con Adam Smith, talora considerato, erroneamente, il padre di quel concetto, dimenticando o ignorando come il filosofo scozzese ritenesse forte ed effettivo il nesso tra simpatia e reciprocità anche in economia.
Si scopre così che le teorie economiche che spadroneggiano oggigiorno sono fondate sulle basi fragili di una psicologia vecchia e sorpassata e di un’antropologia tanto semplicistica quanto ideologica. L’uomo presupposto dal concetto di homo oeconomicus risponde ad una astrazione scientifica che rispecchia un insieme di conoscenze da molti anni abbandonate, perché superate o integrate dalle acquisizioni della psicologia, dell’antropologia e di alcune branche della stessa economia (quella “comportamentale” e quella “sperimentale”). Se solo si insegnassero e divulgassero queste nuove e numerose acquisizioni scientifiche, ebbene, della teoria economica che oggi detta legge, e sulla cui base si giustificano operazioni finanziarie e politiche dagli effetti disastrosi o autolesionisti, resterebbe ben poco. L’attuale crisi globale ha già prodotto altre vittime sul piano dottrinale, oltre al concetto di homo oeconomicus: la rational choice theory e la efficient market hypothesis. Tutte e due fanno capo al primo concetto.
Che un fenomeno storico e concreto come una crisi globale sia questione anche di teoria, già Adorno in qualche modo lo spiegava: i concetti possono padroneggiare il mondo e metterlo in ordine solo attraverso l’utopia, dislocando su un terreno non più reale e completo, ma astratto e mutilato, l’esperienza di uomini e donne. In altre parole, si è da tempo censurato nella pratica quel che il pensiero non riesce, o non vuole, includere nella teoria. È dunque una rigenerazione di pensiero quella che potrebbe darci una mano. Così almeno ci suggeriscono alcuni filosofi, perché questo e non altro possono e debbono fare.
Del concetto di homo oeconomicus esistono almeno due versioni, secondo Caruso: una variante moderata e meno ideologica ed una variante intensificata ed estrema. Quest’ultima arriva persino a concepire un individuo che è “perfettamente egoista perfettamente razionale e, per giunta, incapace di concepire finalità che non siano monetizzabili”. Pur apparendo un assurdo, del tutto implausibile sia come “approdo di una evoluzione naturale”, sia come “approdo di una evoluzione storica”, dobbiamo dire che l’ideologia del “management folle” (Edgar Morin) e del predatore finanziario esiste e si nutre proprio di questa figura caricaturale, che peraltro ha diffuso tramite business schools sparse per il mondo. Sono figure “aliene”, come le definisce l’antropologa inglese Mary Douglas. Niente di più lontano dall’umanità in carne ed ossa.
Eppure è sulla base di questo figurino, e delle caratteristiche ad esso attribuite in astratto e fuori contesto, che si elabora che cosa conta o non conta fare e disfare in economia e nella vita produttiva di individui e popoli. Come scrive Antonio Zanfarino, maestro di Caruso e filosofo di un liberalismo tanto classico quanto oggi rimosso o snaturato, “i fini economici sono fini intermedi da integrare nella struttura pluralistica della coesistenza”. È per questo che oggi non soffochiamo di economia, ma di economicismo, patologia dovuta ad un rovesciamento tra mezzi e fini.
È dall’opposizione a questo rovesciamento che dobbiamo ripartire. Ma come? Il libro di Caruso, molto ricco e suggestivo nella pars destruens, non elude l’esigenza di abbozzare quanto meno traiettorie teoreticamente plausibili e politicamente praticabili. Senza scivolare nell’alternativa con la A maiuscola, quella tanto pura e “altra” che spesso non sa alcunché di economia e dell’effettivo funzionamento degli attuali sistemi capitalistico-finanziari. Si deve perciò guardare, ad esempio, alla behavioral economics e alla politica del nudge, della “spinta gentile”, che poco o nulla ha a che vedere con la vecchia politica degli incentivi economici, mentre punta, attrezzata com’è dalle nuove acquisizioni della psicologia evoluzionistica confermate dall’economia sperimentale, a suggerire agli interessati – agenti economici, sia produttori sia consumatori – certe soluzioni, altrimenti difficili da percepire, e nel renderne evidente la convenienza, altrimenti difficile da calcolare.
Caruso da tempo sostiene che forse non conviene nemmeno parlare più di crisi del capitalismo, semplicemente perché forse siamo entrati in un’epoca diversa, dove tante componenti fondamentali di quel modo di produzione sono venute meno o sono state messe ai margini. Da notare che le nuove strategie di risposta economica alla crisi, a sua volta economica, non nascono dal dibattito culturale europeo, probabile segno di una “cultura vecchia” fondata su scarse conoscenze psicologiche, peraltro datate, e su “un’antropologia immaginaria (tutta ‘naturale’ a destra e tutta ‘sociale’ a sinistra)”.
A livello sia teorico sia sperimentale si sta lavorando nel contesto americano su queste tecniche del nudging, che si cerca di congegnare in modo da creare “percorsi” istituzionali per le scelte di pubblico interesse, invece che lasciare quegli stessi “percorsi” alla consuetudine e al caso. È dunque nel segno di una ricerca di fondate ricette della “crescita” che la critica antieconomicistica viene qui condotta, e non certo per assecondare le sirene della “decrescita”, nota tesi di Serge Latouche che l’Autore dichiara sin da subito di non condividere affatto.
Per chi ne volesse sapere di più e meglio, non dovrà far altro che consultare il volume di Caruso e la sua ricca bibliografia. Per chi scrive resta confermata l’importanza dell’educazione per ogni società che voglia essere e mantenersi “democratica”, per quanto è nei limiti della umana convivenza. L’eterno problema del rapporto fra pedagogia e democrazia, scrive Caruso. E viene da pensare ad un fondamentale che manca all’Italia, di cui si annuncia e/o attende la “ripresa” economica nell’anno venturo.
Volgendo lo sguardo a casa nostra, infatti, comprendiamo quanto sia latitante l’educazione, non solo quella finalizzata ad un diverso modo di intendere l’economia e la natura umana. Ed è facilmente intuibile quanto questa latitanza ci costi, ed inceppi ogni tentativo di riforma ancor prima che lo si provi a congegnare. Basta guardare alle nostre singole esperienze di vita quotidiana, in città più o meno grandi, dentro i negozi, negli uffici pubblici come nelle relazioni private, per rendersi conto di quanta mala educazione (nonché educazione alla “mala”) circola attorno a noi e, perché no?, dentro di noi. Che si debba ripartire da qui pare un’esortazione tanto semplice ed ovvia da risultare non banale, ma elementare, ossia il punto di partenza. E su questo stesso punto si innestano immediatamente le domande fatali: “chi è idoneo ad essere l’educatore?”; e poi: “chi educa gli educatori?”.
Risposte impossibili? Non è detto. Che si rimettano in moto i filosofi, quelli dal pensiero ineludibile, e con essi si riattivi una tradizione dell’Occidente, iniziata con Platone e anche un po’ prima: la filosofia politica come paideia, ovvero uno dei modi usati da questa civiltà per diventare tale. Già, “civiltà”: parola che ha molto a che fare con educazione, intesa appunto come “civilizzazione” degli usi e costumi. Ma parola che abbiamo lasciato gettare troppo frettolosamente nel tritatutto del postmodernismo. L’economia, tanto meno l’economia come forma prioritaria e basilare del sapere e dell’agire umani, non è il Dna dell’Occidente, non è certo tutta la sua storia, non sarà certo tutto il suo futuro.







Commenti (7)
Alessandro Lattarulo
Articolo lucido e, come nello stile del suo autore, poco incline alle interpertazioni convenzionali, gravido di spunti per un superamento dei residui politicisti del Novecento ma non ammaliato dalla sirene del disimpegno edonistico. Un appunto, forse, può rintracciarsi nella titubanza dinanzi al tema della “decrescita”. Può, infatti, non essere quella latouchiana la miglire soluzione, anche per una intrinseca debolezza delle sue basi analitiche, ma, senza dubbio, l’intreccio fondamentale tra civiltà ed educazione è nato all’interno di costumi sociali più sobri e di una civiltà menom complessa e interconnessa di quella attuale, meno affetti dal troppismo che ammorba la temperie attuale. Ovviamente, una strategia di fuoriuscita brusca dall’attuale sistema si condanna in partenza alla sconfitta e all’emarginazione, ma Gaia è una creatura dalle risorse finite, che non può aspettare sommovimenti culturali dalla tempistica secolare.In questo la psicologia sociale poytrebbe giovcare un ruolo centrale nell’aiutare l’Uomo, riscoperto nelle sue dimensioni costitutive, ad essere pro-attivo nel mantenimento di una relazione, fatta di diritto e doveri, anche con le generazioni future, rifuggendo così il solipsismo che lo condanna all’asfissia della solitudine malcelata.
Marco
Hai ragione, l’homo oeconomicus è pura astrazione, tanto è vero che era al centro dell’analisi economica neoclassica, già condannata dopo la crisi del ‘29 come mera teoria da quella straordinaria scuola economica italiana, poi chissà perché dimenticata a beneficio degli economisti inglesi (cito gli studi sull’indeterminatezza economica di Giovanni Demaria, ma anche le analisi di Giuseppe Ugo Papi, del giovane Giuseppe Di Nardi ecc.) .
Negli anni Settanta con il ritorno in auge delle teorie neoliberiste l’homo oeconomicus si è riaffacciato sulla scena (di qui il personaggio di Gordon Gekko negli anni Ottanta). Ma ora un’altra importante fonte di critica a quel concetto viene da ambiti esterni all’economia. In particolare a quelli che si interessano alla “neuroeconomia”.
Cito il passaggio di un saggio di Matteo Motterlini “Neurobiologia della decisione”, pubblicato su Paradoxa 2/2008
“Nelle scelte economiche spesso ci inganniamo. Quando si tratta di risparmiare, spendere e investire non siamo non siamo quei razionali e fulminei calcolatori di “utilità” che popolano i modelli matematici dei libri di economia”.
A scrivere è un filosofo, come se gli economisti, spesso imbrigliati dai loro astratti diagrammi, non fossero in grado di interpretare la realtà (e l’attuale crisi sta appunto a dimostrarlo).
Ma a questo punto il problema non è più solo teorico, ma anche politico:
se l’economia è insufficiente a interpretare la realtà, che possibilità di successo si hanno affidando il governo della crisi a un economista?
Gekko e i suoi figli: la critica dell’homo oeconomicus ai tempi della Nuova Grande Crisi | Nelle tue mani
[…] l’articolo su https://www.istitutodipolitica.it/ Condividi:TweetArticoli […]
Danilo Breschi
Caro Alessandro, hai ragione nel sottolineare come ogni “civiltà” che si rispetti richieda comportamenti e stili di vita ispirati ad una certa sobrietà, ma questo era assai più facile in epoche dove le cosiddette “masse” riuscivano a malapena a sopravvivere. Un senso del limite per necessità, non virtù. Con l’avvento della “società del benessere di massa” sobrietà e misura sono andate a farsi benedire, per ovvie ragioni. Il classico rovescio della medaglia.
Come fare? Può darsi che una crisi prolungata, nel costringere ad una riduzione dei consumi induca un ripensamento generale dei criteri di condotta individuale e collettiva. In questo caso, un rovescio positivo di una medaglia dall’effigie piuttosto negativa. Ma una contrazione, se non una vera e propria stagnazione economica e produttiva, non so quanto bene potrebbe fare alla società in generale, anche perché fuori d’Europa altri popoli si accaniscono con ritmi produttivi e stili di vita che sono all’insegna dello sfruttamento ambientale e dello spreco di risorse, tali da far impallidire il vecchio espansionismo occidentale (Cina docet).
Forse, non si tratterebbe di “inventare” molto di nuovo, ma di recuperare alcuni prìncipi di base che ancora alla nostra generazione, ormai quarantenne (dunque, nemmeno tanto vecchia…), venivano trasmessi e insegnati, in famiglia e a scuola.
In ogni caso, il nesso civiltà/educazione è “il” nodo di tanti problemi attuali. Va pensato e ripensato.
Perciò grazie per il tuo intervento.
Danilo Breschi
Caro Marco, condivido le tue osservazioni circa i limiti e le conseguenze negative di una scienza economica che si fa prassi, anche quotidiana, e che però non contempla l’uomo e la condizione umana per quel che sono. Le critiche e le teorie, anche economiche, alternative, perché più avvedute, esistono da molto tempo, come tu stesso sottolinei. In tal senso, una “battaglia” culturale potrebbe essere intrapresa da studiosi dell’economia, e non solo, affinché un altro paradigma, più “umano”, si affermi.
Sul fatto che un economista al governo non è necessariamente garanzia di soluzione della crisi, né tantomeno di crescita e sviluppo, che dire? In politica non ho mai visto i maghi Merlino riuscire senza che ci fossero attorno ad essi un re Artù e molti cavalieri della tavola rotonda. Fuor di metafora: per quanto bravo uno possa essere, e ammesso e non concesso che lo sia, i miracoli o le magie non si dànno senza la presenza di una previa struttura e senza fondamentali buoni del contesto in cui si va ad operare. Noi scontiamo errori e guasti molto gravi che datano da almeno quarant’anni…
Grazie per il tuo intervento.
Marco
Concordo sugli errori di lunga data. Mi permetto di precisare ulteriormente da quando datano (ovviamente secondo me): da 50 anni (o più precisamente 49…)
Alessandro Lattarulo
Concordo largamente con tutti gli interventi. Del resto, per riferirmi all’intervento di Danilo, la neurobiliogia della decisione è ormai largamente indagata ed applicata da tutti gli esperti di marketing. Il dramma vero è che non si intravvede una via d’uscita. Con una battuta: persino il combattivo Bauman, che pure so tu non ami moltissimo, mi sembra piuttosto disarmato nell’ultimo libro edito in Italia, “Cose che abbiamo in comune”. E’ altresì vero che la strategia cacciariana del “tramonto” quale momento di rottura rispetto all’ordine delle cose esistente è anche secpondo me piuttosto debole. In questo senso, lo sono anche le strategie della decrescita meno attente alla redistribuzione e all’aspetto isituzional-legislativo globale. Bisogna in altri termini capire se il disastro debba essere per tutti – il che significa disastro immediato per chi già non possiede nulla, anche all’internod elle società occidentali, e procrastinato per i ricchi – o solamente per qualcuno attraverso una lunga fase di riposiznamento geopolitico degli Stati attraverso strategie belliche di media durata. La questione dei paesi emrgenti, che adesso reclamano un loro spazio e pensano allo sviluppo secondo parametri di rampantismo e sfruttamento delle risorse simili a quelli che noi occidentali abbiamo già sperimentato, il punto è che per poter con loro condividere regole mondiali, dovremmo essere i primi ad abbatter i consumi e il depredamento delle risorse naturali. Pena l’essere privi di alcuna legittimazione nel pretendere da chi non ha banchettato lautamente come noi, un po’ di misura. Ci vorrebbe politica, non economia (o, forse, meglio: finanza) al potere, ma sinceramente non riesco a intravvedere una percorribile strada per liberarsi da un complesso di regole e di vincoli che le grandi corporations e le grandi banche hanno messo in piedi. Del resto, pur se non nuova, condivido largamente la tesi di Crouch secondo cui ragionare in termini dicotomici di Stato e Mercato sia un vetusto retaggio novecenetesco. Esiste quanto meno un terzo soggetto che ormai ingloba le altre due sfere, anche perché ne influenza irrimediabilmente il funzionamento: le grandi corporations, appunto. Ma nessuno ha ancora in mente come fare per sgonfiarle.